La Scuola è nuda
racconti di insegnanti
di Roberta Dell’Ali
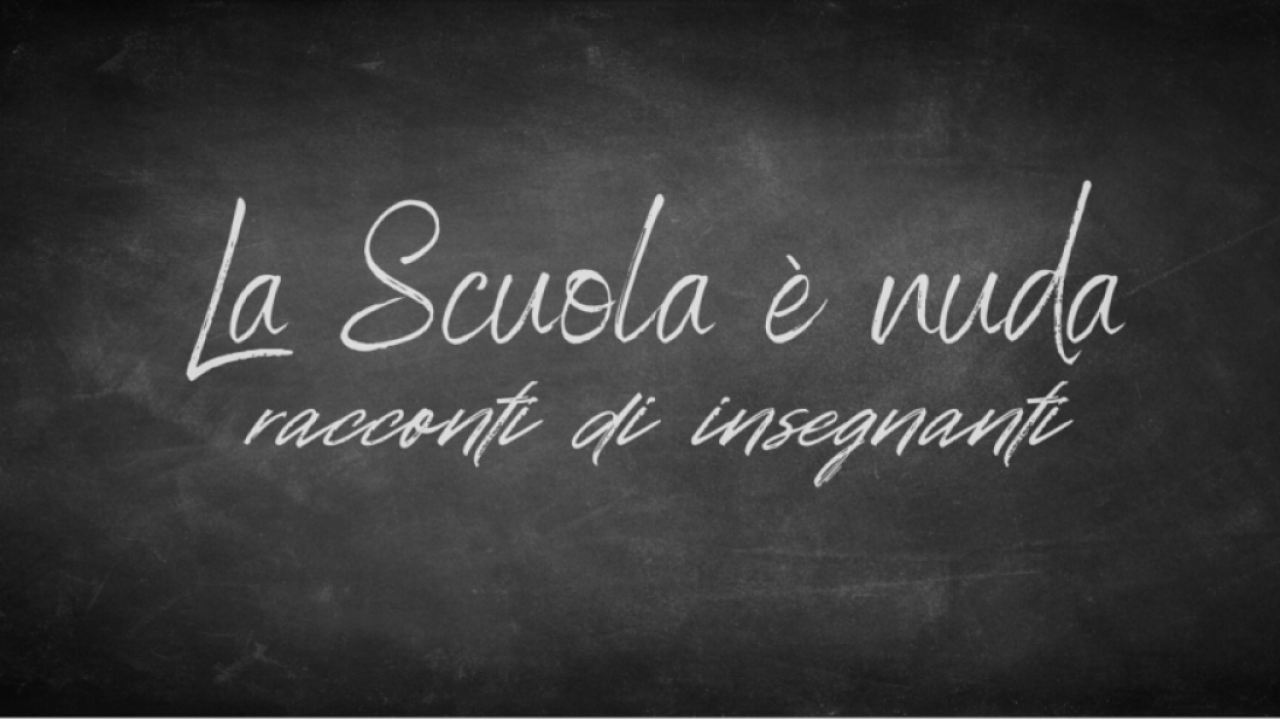
La Scuola italiana è nuda, come il Re della favola di Andersen. A spogliarla, questa volta, il Covid-19. C’è di buono che finalmente quest’istituzione è tornata al centro del dibattito.
L’universo Scuola, sminuzzato in migliaia di identità, taglia trasversalmente diverse generazioni ed esigenze, molteplici ruoli e servizi. Guardando alle stelle che orbitano in questo universo collassante, mi sono chiesta chi interrogare per capire. Studenti? Dirigenti? Genitori? Personale ATA[1]? Sarebbe bello e giusto parlar con tutti loro, ma lo spazio è quello che è. Per questa volta ci concentreremo sugli insegnanti.
Metto subito le mani avanti: l’esplorazione di questa galassia forse apparirà un po’ confusionaria, ma vi giuro che qua dentro si capisce poco. Approfitto della premessa anche per chiedere scusa ai miei bellissimi intervistati: ho dovuto ridurre all’osso le complessità infinite vostre e della scuola italiana, mi farò perdonare.
«I bambini sono persone»
Questo tour de force nella scuola italiana, dalle elementari alle superiori, da Torino a Catania, inizia con C., una giovane insegnante sognatrice.
C. ha ventisette anni, è minuta e sulla testa ha lunghissimi capelli castani. C. ha studiato Scienze della Formazione Primaria a Torino e lavora come supplente nelle scuole elementari piemontesi da un anno e mezzo – anche se tra tirocini e ricerca per la tesi frequenta l’ambiente scolastico già da sette anni.
La cosa bella di C. è la voglia di insegnare e raccontare il mondo dei bambini. Mi è piaciuto molto come mi ha risposto quando le ho chiesto cosa l’abbia spinta a scegliere di essere una Maestra:
C. Credo sia stata l’idea di cambiare, o meglio di far parte delle vite dei bambini, che sono persone. Persone in crescita ed estremamente sottovalutate, spesso tagliate fuori dalle decisioni: senza voce in capitolo. Sempre trascurate, in particolare per entità di percezione ed emotività.
Quello che emerge dalle parole accorate di C. è il distacco tra la sua idea di scuola e la realtà scolastica effettiva:
C. Per me, per quello che ho studiato, la scuola d’infanzia e primaria dovrebbero dialogare con i bambini, partire dalle loro percezioni e conoscenze per accompagnarli alla scoperta del mondo. Si tratta di capire insieme a loro la realtà intorno e favorirne la libertà di pensiero: permettere ad un bambino di esplorare ed esplorarsi. Invece non è così, nelle aule a tratti sembra accadere l’opposto.

La cosa più bella del racconto di C. è la descrizione della sua scuola ideale, con classi aperte e senza porte. Una scuola piena di laboratori d’arte e musica, perché «la creatività è estremamente sottovalutata e ai bambini è negato di esprimere questa potenzialità». Nella scuola di C. ci sono enormi spazi aperti: «I bimbi fanno merenda fuori e sperimentano le stagioni e i climi sulla loro pelle. Basta co ‘ste foglie secche attaccate su bianchi rettangoli A4!» sbuffa C.
La scuola di C. è soprattutto dialogante, è aperta all’astratto: parla di amore, amicizia, alterità e uguaglianza. La scuola di C. racconta le fiabe.
«Vorrei che Azzolina entrasse nelle classi e capisse»
Signori e signori, vi presento R., appassionata quarantottenne, che vive a Catania: insegnante di sostegno «per scelta» da ormai vent’anni.
Con R. facciamo una video-call ché tanto ormai è un’esperta di Zoom. Risponde al primo squillo e mi riempie lo schermo con un sorriso a zigomi alti: «Non mi aveva mai intervistata nessuno, mi sento importante» mi dice, però arrossisco io.
R. ha una gran parlantina, mi racconta per sommi capi le tappe della sua carriera: magistrale, supplenze, laurea nel ’90, altre supplenze, sette anni di incarichi annuali in Pavia e provincia. Poi corsi, formazioni, laboratori freudiani, il passaggio a ruolo nel 2009 e finalmente, nel 2011 il ritorno nella sua Catania: «Mi mancava il mare» dice in un soffio.
Com’è stato il rientro a Catania?
R. Ero molto felice di essere a casa, ma i primi anni sono stati scolasticamente difficili. Ho insegnato in delle scuole di frontiera, a Fortino, una zona problematica di Catania; lì ho visto situazioni indescrivibili, che fanno male al cuore, realtà per cui non c’è cura né attenzione.
Ci sono sacche di disagio enorme nella nostra società, vorrei che Azzolina entrasse nelle classi e capisse cosa significa stare in strutture senza tavoli, gessi e banchi a sufficienza.
R. lavora da ormai molto tempo come insegnante di sostegno e mi racconta con trasporto dei suoi bambini. La vedo commuoversi quando mi dice l’emozione di Chiara che impara a leggere dopo tanti sforzi e tanti anni, Chiara la sua prima alunna che «ormai è una donna».
Le parole di R., oltre a tanta bellezza, raccontano una negligenza pesante a opera del Ministero e del corpo docenti. L’amarezza della sua voce arriva al culmine quando mi racconta di Manuel, «u ghoia miu»[2]. L’appellativo è vero, il nome di fantasia.
R. Essere un’insegnante di sostegno significa innanzitutto non avere sostegno. Nella maggior parte dei casi il nostro ruolo di maestr* si riduce al tenere i bambini fuori dalla classe, la cui funzione viene assorbita in toto dall’insegnante di sostegno.
Manuel è un bambino che seguo da ormai tre anni, da quando ne aveva 7. Lui è un bambino molto fragile, è un F93, il ché in questo caso vuol dire una sfera emozionale tagliata in due, un’emotività drammatica che fatica molto a sostenere il senso dell’altro.
Il primo giorno che sono entrata in classe, quando ho preso Manuel in carico, lui stava rannicchiato a terra, vicino al cestino. Piangeva e basta. Non sapeva né leggere né scrivere e le mie colleghe non pensavano competesse loro coinvolgerlo o aiutarlo.
La buona notizia è che Manuel oggi, alla veneranda età di dieci gloriosissimi anni, è un bambino splendente. Legge moltissimo e bene ed ha sviluppato un amore spropositato per Prometeo – sospetto per influenza della maestra, stupendamente incline al mito e alla letteratura.
Nell’innamoramento per la storia di Manuel mi viene naturale chiedere a R. come siano andati questi mesi di lockdown e DAD (per i profani, Didattica A Distanza):
R. Per Manuel la DAD non è stata proponibile, senza considerare che inizialmente non aveva nemmeno un dispositivo con cui fare lezione, è stata la scuola a prestargli un tablet.

La scuola online è la depersonalizzazione totale dell’insegnamento: i bambini erano scompensati, scappavano e si nascondevano. Spesso Manuel mi diceva che non capiva ed era stanco: non siamo riusciti a fare quasi niente di nuovo, solo un po’ di analisi grammaticale al telefono.
In ogni caso da due settimane io e Manuel abbiamo iniziato a vederci ogni sabato mattina a casa mia, così recuperiamo il condizionale e gli avverbi. Le mie colleghe dicono che non sono professionale, ma io me ne fotto, non voglio lasciare Manu indietro… la parolaccia toglila eh [R. ti chiedo scusa, ma dovevo lasciarla perché fai bene].
The MAD people
M. e S. sono due ventiseienni rampanti che vivono a Bologna, una letterata e uno storico. L’intervista s’è svolta in una chiamata a tre su WhatsApp: tutt’ e due belli come il sole. Uno a Marsala e l’altra in Abruzzo.
M. e S. sono stati interpellati dalla mia curiosità in quanto rappresentanti del popolo MAD.
La MAD, nota anche come Messa A Disposizione, è una creatura temibile che domina le vite di moltissimi giovani insegnanti. Un mostro famelico che mangia un po’ tutti, ma ha un particolare amore per il sapore agrodolce dell’umanista.
Questa cosa immaginatela un po’ come se fosse un’intervista a due delle Iene, okay? M. sta nel riquadro a destra, S. a sinistra. La prima cosa che voglio sapere è come definirebbero la MAD:
M. Mm… io l’ho sempre spiegata come una disponibilità privata che tu mandi alla scuola. Una candidatura spontanea, estranea a ogni tipo di graduatoria o fascia. Tu comunichi alle singole scuole che sei a disposizione per riempire le cattedre scoperte.
S. Mah… secondo me ci sta dire che la Messa A Disposizione sia esattamente un mettersi a disposizione. Mi sembra che concluda da sé il significato: tu ti metti a disposizione del buco che devi tappare… Questa però non è una definizione, non la puoi mica scrivere! [E invece sì, la scrivo]
S. e M. si sono laureati l’anno scorso, entrambi a marzo del 2019. Da allora hanno (quasi) sempre lavorato nelle scuole come supplenti, inviato MAD in tantissime scuole in tutta Italia.
M. ha lavorato per due mesi in un liceo artistico in provincia di Reggio Emilia, poi in una scuola media in provincia di Parma, otto mesi di servizio per un totale di quattordici rinnovi di contratto. S., dal canto suo, ha tastato varie province: Reggio Emilia, Ravenna, Milano, Torino, Modena e Ferrara.
Quando gli chiedo un commento sul sistema MAD mi rispondono così:
S. Io ho l’impressione che il sistema MAD sia totalmente casuale: non tiene conto delle competenze né delle precedenti esperienze. Tutto è volto alla casualità. Tu invii una domanda preimpostata alle scuole e, a volte, all’improvviso, giunge la chiamata di una scuola come grazia divina.

Nella maggior parte dei casi chi chiama non si preoccupa di verificare le competenze del candidato MAD e nemmeno di informarlo su quel che deve andare a fare.
Io l’anno scorso mi sono ritrovata a fare un sostegno alle elementari, senza essere preparata e tanto meno avvisata: buttata dentro la scuola.
L’esperienza di M. è grosso modo la stessa e fa emergere un altro punto cogente: la totale instabilità creata da sistema MAD:
M. La burocrazia e le segreterie spesso sono un ostacolo, la questione più avvilente è quella contrattuale, priva di qualunque prospettiva di stabilità, sulla quale non abbiamo nessuna voce in capitolo. Loro ti chiamano, tu puoi solo rispondere sì o no. Il tempo per riflettere non c’è: sì o no?
Per non parlare poi dei rinnovi di contratto: non è mai comunicato per tempo, se lo fanno è un favore. E se questo è un disagio per noi, the MAD people, è un disastro emotivo e relazionale per gli studenti: quest’anno ho visto piangere la mia classe infinite volte, ogni quindici giorni, per un intero anno, ho annunciato la possibilità che non ci potessimo vedere più. Una relazione che nasce e cresce nell’ombra della fine.
Mentre parliamo è un pigro martedì di giugno e nel cielo marsalese di M. iniziano a rimbombare dei fuochi di artificio, non capiamo perché ma la cosa ci fa ridere. La conversazione prosegue ed emerge un dato tanto curioso, quanto noto:
S. La situazione a scuola è sempre drammaticamente immobile. Credo che il problema sia proprio questo: diventare insegnanti a pieno titolo è così difficile e angoscioso che poi le persone, una volta preso il posto, non lo mollano più.
L’idea che mi sono fatta in un anno e mezzo a scuola è che l’insegnante di ruolo sia tendenzialmente uno che non ha voglia di lavorare e trova tutti gli escamotage possibili per non farlo. È come se una volta che si è di ruolo il posto non te lo possa togliere nessuno: tutto diventa concesso.
Quest’anno, a Ferrara, ho supplito per cinque mesi (con quattro rinnovi di contratto) un docente che era noto per la sua attitudine all’assenza: uno che non lavora per niente, neanche quando è in classe ché crea un sacco di problemi e va avanti così da anni. Eppure ha percepito il 100% dello stipendio e conserva il suo posto fisso.
Quasi sempre dalle scuole viene dato per scontato che tu agisca come se quello fosse il tuo posto, nonostante tu sia solo un supplente con un contratto che dura – forse boh chissà – una settimana. Pretendono che tu sia in grado di dire: “sì, faccio la coordinatrice” o “sì, certo, li accompagno io in gita ad aprile anche se il contratto scade a Marzo”. Alla fine, però, sembra solo di essere alla mercé degli umori dei docenti di ruolo.
M. concorda su tutto, ha esperito sulla sua pelle le stesse mancanze. Poi confessa un po’ romanticamente che vuole fare l’insegnante «perché stare in aula è proprio fico. È emozionante vedere l’interesse scatenarsi in un sedicenne davanti a una poesia o una canzone. Ed è impagabile leggere come ogni studente declini ciò che ha imparato attraverso le proprie emozioni e inclinazioni».
«Siamo preda degli avvocati e dei politici»
Perdonatemi se salto un po’ di palo in frasca: il dono della sintesi ce l’ho a metà, invece a far salti pindarici son bravina.
A metà giugno, una mattina calda calda, sono passata a salutare F.: quarantanove anni, occhi giganti e verdi che mi incantano, nonostante la conosca da sempre. F. è madre di due figli ormai adolescenti, è siciliana e vuole restare a casa sua.
F. fa parte di quella categoria di insegnanti che passano la vita a fluttuare in cima alle graduatorie, navigando nel mare magnum di punteggi, fasce, leggi e attese. Ha recentemente ottenuto il passaggio di ruolo, ma con la beffa di contorno: sede prima ad Arezzo e poi a Roma, dopo una vita immolata al precariato per rimanere al Sud.
F. Da quando ho iniziato io a ora, la struttura della scuola è completamente diversa. Io mi sono laureata nel ‘99 e il concorso era uscito qualche mese prima. Il successivo concorso per le superiori è stato nel 2016. Questo era l’andamento normale: graduatorie che rimanevano 16-17 anni, però c’era anche la GAE, graduatoria ad esaurimento.
Dal 2016 le cose sono cambiate: la legge 107 stabilisce che ogni due anni ci debbano essere concorsi. Il ché sarebbe anche giusto, se non fosse che c’è gente che ancora aspetta dal 2016 e resta ancora sospesa, con anche i concorsisti del 2018. Anzi, che dico, il concorso del 2016 nel frattempo è decaduto.
F. ha avuto supplenze mediamente lunghe in quattordici, senza contare tutte le miriade di supplenze brevi né i paritari: «Qui nei dintorni ho insegnato a tappeto in tutta la provincia di Ragusa (Vittoria, Modica, Scicli, Pozzallo, Ispica…) poi anche a Siracusa, Avola, Rosolini, Agrigento e Licata. Ultimamente anche ad Arezzo e Roma» dice F., e si rabbuia.
Mentre mi racconta l’iter infinito che l’ha condotta a Roma, vengono fuori storture infinite del sistema. Mi racconta di tanti sotterfugi burocratici spudoratamente attuati da enti ed istituzioni, poi F. mi porge la tazzina col caffè e, rassegnata, mi dice: «In Sicilia funziona così».
La carriera (e di riflesso buona parte della vita) di F. si snoda attraverso traumi legislativi: Gelmini, le classi pollaio e, poi, la ferita più grande: la legge 107.

F. La legge 107 di Renzi ha creato una confusione indecente. La famosa legge delle 100 province che doveva risolvere il precariato scolastico. Sì, certo. Peccato che io abbia due figli, un marito, una casa una vita, quasi cinquant’anni e la sede scolastica a Roma, che non mi appartiene e che non ho scelto.
Con la legge 107 noi che eravamo in GAE siamo finiti sparsi: tra i compagni di graduatoria, la precedenza di restare è andata a chi aveva figli piccoli, giustamente; gli altri posti sono andati ai vincitori del concorso del 2016. A noi sono rimasti gli scarti: i posti sul cozzo della montagna, quelli che non vuole nessuno.
La 107 è stata una violenza, un aut aut: “Tu insegnante che sei nella GAE, o fai la domanda e io ti porto dove voglio oppure la GAE il prossimo anno non esiste più e quindi stai a zero”. In realtà poi non è stato così con la GAE: son stati messi in mezzo avvocati.
Si sono dimenticati di noi. Tre anni fa fiottavano promesse di tempi celeri, Di Maio sventolava slogan, come tutti. È il 2020 e siamo sempre qui.
Ascolto F., la vedo trattenere la rabbia col pugno stretto sul tavolo. È stanca, triste, in fondo arresa. Mi torna in mente una celebre frase: “Bisogna cambiare tutto per non cambiare niente”, ed è proprio vero.
«Credo che sia una questione tipicamente italiana»
Dulcis in fundo, amici miei, c’è G. Ultima voce di questa saga un po’ curiosa, una voce acuta e abile a osservare.
G. è una professoressa sessantenne di Latino e Greco; in parte se sono finita a fare quello che faccio è un po’ colpa sua (e per questo le voglio bene). G. è sempre molto elegante, anche adesso mentre sorseggiamo tè fresco e granita al limone, circondati dai fiori della sua veranda.
Lei ha iniziato a insegnare nel 1992, con delle supplenze in un liceo, poi per qualche anno anche in scuole private. Nel ’98 una lunga supplenza per la cattedra di Filosofia. Nel 2000 partecipa al concorso e cinque anni dopo passa definitivamente passata di ruolo.
G. Il classico percorso di un docente medio della scuola italiana: precariato per tanto tempo in diversi posti, poi finalmente il concorso e, dopo qualche anno, il ruolo. Io sono stata anche fortunata perché ho potuto scegliere di fare quello che volevo, cioè latino e greco.
Conosco G. da un bel po’ di tempo ormai ed ero profondamente convinta che lei fosse stata sempre di ruolo. Scoprire che anche lei ha vissuto un lungo periodo di precariato fa crollare quell’idea aurea che avevo della passata scuola italiana. Ingenuamente le chiedo se il precariato c’è da sempre e lei mi risponde così:
G. Certo, da sempre e per sempre. Alcune volte s’ingolfa, altre si diluisce, poi s’ingolfa di nuovo: io sono stata precaria per molto tempo, allora come ora, le leggi continuavano a cambiare: adesso si passa di ruolo più giovani, ma è un dato relativo.
G. dice così e le campane della chiesa dietro casa sua iniziano a suonare rumorosamente: curioso, non vi pare? Parlo con G. per un bel po’: forse toccherà anche a me di far la professoressa e ho bisogno di capire. Quali sono le crepe della scuola? Da dove iniziare a ricostruirla?
Secondo G. «la falla più grossa del sistemo scolastico italiano è nella formazione dei quadri: non si arruolano così i docenti».
G. Non si possono selezionare gli insegnanti solo in base al criterio della conoscenza. È necessario valutare anche la nostra competenza di docenza: non è possibile che non esista nella formazione della scuola italiana un percorso psicoattitudinale per gli insegnanti. E credimi, Roberta, non sono baggianate.
Sono molti i docenti che insegnano tanto per insegnare, perseguendo obiettivi trasversali che niente hanno a che vedere con la costruzione del cittadino. Questo è importante ovunque nella scuola, ma è particolarmente incisivo alle superiori. Noi lavoriamo nella fase finale della formazione di un individuo, la fine di un percorso da cui viene fuori la persona, il lavoratore, l’universitario. Questo scrivilo, ci tengo.
Secondo G. l’altro grande problema della scuola italiana è di ordine strutturale-logistico:
G. La condizione strutturale della scuola, in senso fisico, è impraticabile: le scuole italiane sono mediamente vecchie e obsolete.

La scuola è un luogo in cui delle persone vivono un terzo della loro giornata (parlo di docenti, studenti e personale). Mi sembra il minimo allora che le scuole somiglino più a luoghi in cui vivere e non, come attualmente, a luoghi di sopravvivenza.
La questione è capillare. In questo periodo, per ovvie contingenze storiche, ci ritroviamo a parlare di “scuola digitale”. Ma manca tutto: la strumentazione, la rete, i computer e lo spazio per vivere il computer e la rete. Parliamo da sempre di progetti pomeridiani e poi non abbiamo lo spazio per fargli mangiare il panino. Sono problemi, vanno risolti.
La chiacchiera con G. volge al termine, sto recuperando il tabacco dal tavolo e ho già chiuso il quaderno dove ho appuntato tutte queste storie di insegnanti. In calcio d’angolo commento le sue ultime affermazione e le chiedo un po’ retoricamente se le istituzioni e la politica si curino dei nostri studenti. G. fa una smorfia:
G. No. E mi sono sempre chiesta se al ministero ci siano dei pazzi, in questo periodo più che mai. Credo sia una questione tipicamente italiana: esiste nella nostra società un duplice scollamento. Il primo tra il Paese reale e la politica, l’altro tra il Paese reale e i ministeri – che dovrebbero essere altro dalla politica.
È tutta una classe di burocrati che non sa di cosa parla. Ho sempre l’impressione che sfugga al ministero ciò che avviene a scuola, come se quello che facciamo tutti i giorni non gli interessasse o non lo sapessero affatto.
[1] Personale ATA: personale Amministrativo, Tecnico, Ausiliario (cfr. segreteria, bidelli, tecnici di laboratori, bibliotecari, etc. etc.)
[2] Traduci: la mia gioia

